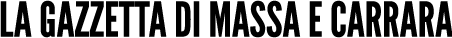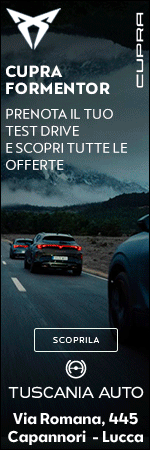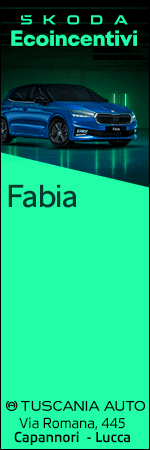Arriva da Arca un'attenta anilisi sul sito dell'ex hotel Mediterraneo: "Tra cementificazione, vincoli ignorati, opportunità PNRR mancate e democrazia dimezzata, la storia dell’ex Mediterraneo a Marina di Carrara è un paradigma nazionale delle contraddizioni ambientali e urbanistiche del nostro tempo. Nel cuore di Marina di Carrara, una colata di cemento lunga oltre un decennio racconta molto più di un cantiere abbandonato: è la radiografia di un’intera politica urbana, fatta di vincoli elusi, promesse mancate e verde pubblico cancellato. Questo dossier documenta i passaggi tecnici e amministrativi che hanno trasformato un giardino vincolato in un’area degradata, e solleva interrogativi sulla gestione dei beni comuni, sull’uso distorto dei fondi europei e sulla crisi della partecipazione democratica. Ma pone anche una domanda semplice e cruciale: vogliamo ancora vivere nel cemento?
Ex Hotel Mediterraneo: un caso emblematico di criticità urbana e ambientale
Negli ultimi anni, l’intera area compresa tra l’ex Mediterraneo, viale Colombo, via Genova e Caravella è stata interessata da numerosi abbattimenti arborei, spesso privi di perizie strumentali e non sempre giustificati da eventi climatici eccezionali, come il downburst del 2022. Tali abbattimenti non sono mai stati accompagnati da un autentico piano di reimpianto vegetale, trasparente e verificabile. Nel frattempo, l’amministrazione ha continuato a evocare termini come “well life” (forse intendendo “well being”), “rigenerazione urbana” e “turismo sostenibile”, promuovendo progetti e fondi europei mentre, concretamente, il paesaggio viene eroso pezzo dopo pezzo. Non si tratta soltanto di un cantiere abbandonato o di un albergo demolito. L’ex Hotel Mediterraneo è il cuore simbolico di un modello urbano fallimentare, un microcosmo di contraddizioni che si estende all’intera zona portuale e cantieristica di Marina di Carrara: un territorio gravemente compromesso da traffico pesante, emissioni industriali, speculazioni fondiarie e una gestione opaca del verde pubblico. Documenti tecnici, giuridici e ambientali impongono una svolta: occorre ripensare in modo radicale le politiche urbane, a partire dalla riconversione delle aree dismesse in spazi verdi pubblici, fruibili e sani.
- Un vuoto urbano nel cuore della città Nel centro di Marina di Carrara, tra via Genova e via Nazario Sauro, a pochi metri dal mare e dalla sede della Guardia di Finanza, si estende oggi una colata di cemento di oltre 5.500 metri quadrati. Qui sorgevano l’Hotel Mediterraneo, il Cinema Vittoria, la Casa del Portuale e un giardino pubblico vincolato. Tutto demolito per far posto a un complesso edilizio privato con albergo e parcheggio interrato da 111 posti. Il progetto è rimasto incompiuto, ma la colata di cemento è rimasta: fondazione di 80 cm, solaio di 25 centimetri, parcheggio interrato allagato e inutilizzabile.
- Un giardino pubblico cancellato Il giardino storico, sottoposto a vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004, artt. 10, 134, 142), fu rimosso con autorizzazione paesaggistica n. 118/2012, a condizione del ripristino integrale al termine dei lavori (art. 146). L’impegno è stato disatteso. Il giardino non è mai stato ripristinato. L’area, chiusa e impermeabilizzata, è sottratta all’uso collettivo da oltre dieci anni. Va aggiunto che l’intera autorizzazione era viziata da un presupposto inverosimile: ripristinare un giardino sopra una soletta pensile.
- Concessioni scadute e responsabilità eluse
- Titoli edilizi scaduti nel 2013 per mancato avvio dei lavori;
- Concessione demaniale decaduta nel 2014;
- Vincoli contrattuali disattesi: l’ex Casa del Portuale, ceduta nel 1939 al Comune con vincolo d’uso, in caso di variazione prevedeva il pagamento del “giusto prezzo” stimato con perizia. Nel 2014, valutata in 1,7 milioni di euro, la cifra fu definita “pretestuosa” dalla società proprietaria, senza che il Comune intraprendesse azioni per il recupero;
- Fideiussione da 800.000 € riscossa dal Comune dopo causa legale, da destinare alla riqualificazione del giardino e della pineta, ma tuttora senza tracciabilità sull’utilizzo.
- Acquisto pubblico con rinuncia ai diritti Nel 2022 il Comune ha acquistato l’area per 1,28 milioni di euro (+ IVA), chiudendo il contenzioso (R.G. 1773/2016) e rinunciando:
- al ripristino del giardino, mantenuto illegalmente oltre scadenza;
- a ogni pretesa risarcitoria;
- al valore accertato dell’area nel 2014. Un atto che legittima l’inadempienza della proprietà privata, configurando un potenziale danno erariale (D.lgs. 174/2016, art. 52) e una grave violazione dell’interesse pubblico.
- Cemento sotto il tappeto: maquillage da 50.000 euro Nel 2023 l’Amministrazione ha speso quasi 50.000 euro per installare una recinzione opaca e impattante, presentata come intervento di “riqualificazione visiva”. Una soluzione puramente cosmetica: il degrado rimane, solo nascosto alla vista. Si tratta di una "pulizia visiva" che occulta, ma non risolve.
- Un degrado che va oltre l’estetica: le criticità tecniche Secondo la relazione dell’ing. Ottani:
- la falda acquifera si trova a 30 cm dal piano campagna;
- l’interrato è instabile e zavorrato con 2 metri d’acqua, senza alcuna valutazione sanitaria (es. rischio legionella);
- gabbioni metallici occupano il 32% del parcheggio, durano meno di 10 anni e hanno un bilancio statico insostenibile;
- materiali di scavo non analizzati pubblicamente, conferiti a un impianto già indagato per smaltimenti illeciti;
- documentazione geologica mancante e nessun monitoraggio su cedimenti negli edifici vicini. Un quadro che impone verifiche immediate da parte di ARPA/ISPRA e un piano di sicurezza sanitaria (D.lgs. 81/2008).
- Partecipazione pilotata e democrazia dimezzata Il processo partecipativo promosso dal Comune ha escluso l’opzione più radicale e coerente: demolire il cemento, restituire suolo vivo. Nessun campionamento rappresentativo, linguaggio binario, assenza di confronto pubblico sui dati tecnici. Le alternative discusse erano tutte fondate sul mantenimento del basamento in cemento:
- cementificazione mascherata da verde pensile;
- edilizia leggera ecosostenibile;
- ripresa del progetto originario (un albergo).
Lo stesso processo partecipativo ha tuttavia evidenziato, non solo nel suo “nomadismo” itinerante alla ricerca di un luogo, ma anche nei contributi dei cittadini, la necessità di uno spazio pubblico multifunzionale, con funzioni culturali, educative e aggregative. Alcuni hanno avanzato proposte orientate alla bioedilizia: edifici a impatto quasi zero, realizzati con materiali naturali e reversibili, destinati a laboratori, sale civiche, coworking, spazi verdi coperti e aperti alla cittadinanza. Esempi simili sappiamo già essere realtà in molte città italiane – dal Bosco di Ostia al Parco Dora di Torino – dove l’architettura sostenibile è stata adottata per riqualificare ex aree industriali, come anche il piccolo “Teatro di Terra” a Carrara. Purtroppo, però, nessuna di queste proposte ha messo in discussione il presupposto più illogico: la permanenza della colata di cemento. la vera sfida è costruire senza sigillare il suolo perché il cemento impedisce all’acqua piovana di infiltrarsi provocando aumento delle acque di ruscellamento, perdita della ricarica delle falde acquifere, morte biologica del suolo sottostante, aumento delle isole di calore urbane. Anche chi si mostrava sensibile alla bioarchitettura ha accettato come inevitabile quel basamento, vanificando in partenza la coerenza ecologica delle ipotesi progettuali: la coltre di cemento quale precondizione tacitamente accettata che struttura il campo del dibattito. È questa la vera contraddizione: parlare di sostenibilità, ma sopra 5.500 mq di calcestruzzo. Green superficiale, stricto sensu e non solo.
- Verde pensile o foglia di fico? Il “verde pensile” proposto assomiglia più a una foglia di fico che a un progetto ecologico:
- terreno troppo sottile per piantare alberi;
- costi alti di irrigazione e manutenzione;
- assenza di biodiversità reale;
- parcheggio interrato non agibile senza nuovi investimenti.
Inoltre, si configura:
- una violazione normativa: il giardino storico non è stato ripristinato (D.lgs. 42/2004);
- un processo partecipativo predeterminato, con esclusione delle vere alternative.
- Opportunità PNRR ignorate L’area poteva accedere a:
- Missione 2 (Green): 275.000 € per deimpermeabilizzazione dei suoli;
- Missione 5 (Inclusione): fondi per verde urbano. Nessuna progettazione alternativa risulta attivata.
- Un terreno che non poteva essere venduto L’area era parte del patrimonio indisponibile dello Stato, assegnata alla Guardia di Finanza. La sua successiva riclassificazione come disponibile (atto notarile 28/05/2022) risulta in contrasto con:
- art. 823 c.c.;
- L.R. Toscana 65/2014. Possibile violazione del principio di inalienabilità dei beni pubblici.
- Le voci rimaste inascoltate Tra il 2013 e il 2016, l’arch. Claudia Bienaimé presentò numerose interpellanze consiliari, mai realmente discusse. Un ulteriore segnale di chiusura e opacità che ha attraversato le diverse amministrazioni.
Conclusione – La vera scelta: cemento o città vivibile Marina di Carrara ha ancora davanti un bivio:
- continuare a mascherare il fallimento con maquillage costosi;
- oppure demolire il cemento, restituire suolo vivo, ripristinare il giardino pubblico, dare nuova vita alla città.
Il vincolo paesaggistico è tuttora vigente, e l’obbligo di ripristino è chiaro. L’ex Hotel Mediterraneo è il simbolo di una città che promette rigenerazione urbana ma produce solo vuoti, fondi PNRR ignorati, spazi pubblici cancellati e memoria collettiva dissolta.
Per invertire la rotta servono coraggio, trasparenza: serve una svolta che non è (solo) tecnica, ma (soprattutto) culturale e politica.
E, soprattutto, serve una cittadinanza attiva, vigile, consapevole. Noi non siamo esperti, ma ci impegniamo a interpretare i dati con onestà. Chiediamo il supporto di chi ha saperi tecnici, mossi non da interessi personali, ma per etica della res publica. E non sarebbe poco"